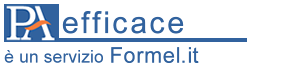PUO’ UN COMUNE COSTITUIRE UNA FONDAZIONE CON FINALITA’ NON STRETTAMENTE ISTITUZIONALI?
PUO’ UN COMUNE COSTITUIRE UNA FONDAZIONE CON FINALITA’ NON STRETTAMENTE ISTITUZIONALI?
05 Novembre 2020
Nel parere espresso dalla Corte dei conti sez. di controllo per la Regione Veneto n. 130 del 19 ottobre 2020, viene fornito un riscontro alla questione se, alla luce dei vigenti principi giuspubblicistici in materia di contabilità pubblica, onde garantire il rispetto dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’ente nel lungo periodo, l’Amministrazione comunale possa costituire, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti alla titolarità comunale ed inoltre, se del caso, quali garanzie di natura economico-patrimoniale possano essere legittimamente assunte per la costituzione stessa.
La Corte ha sottolineato che il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d’agire, può attingere (sotto il profilo dell’“an”), a particolari condizioni (sotto il profilo del “quomodo”), a moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444).
Il modulo della fondazione è regolato dagli artt. 14 e ss. c.c., rimanendo, ordinariamente, distinto dai moduli prettamente societari (art. 13 c.c.). In tal senso, le fondazioni hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui al richiamato art. 118, comma 4, Cost., un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).
In particolare, le fonti legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione sono quelle, testé citate, corrispondenti ai commi 561 e 562 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) e all’art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016.
Nel caso di specie, la fondazione origina dal comune co-fondatore e da un soggetto privato, profilandosi la cosiddetta fondazione di partecipazione. Quest’ultima risponde all’esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell’elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione (o istituzione), con quello associativo, ascritto alle associazioni (o corporazioni), in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici o privati (come nel caso di che trattasi), alla costituzione dell’organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato.
Tale connotazione rispetto all’originario modello privatistico (cfr. Cons. Stato, Parere n. 288 del 20 dicembre 2000) è ascrivibile, oltre al richiamato principio della capacità d’agire degli enti pubblici, all’art. 118, comma 4, Cost. che impone espressamente ai comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del generale principio di sussidiarietà orizzontale. In tal senso, il principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., siccome modificato dall’art. 2 L. cost. 1/2012, “tramite criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità ha favorito un nuovo rapporto tra la spesa pubblica e privata, espresso nella formula, propria del diritto comunitario, di partenariato pubblico-privato” (Corte dei conti, sez. controllo FVG/ 22/2019/PAR, cit.).
La Corte ha ricordato che la possibilità di attingere da parte dell’ente pubblico a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) è soggetto a particolari condizioni di ammissibilità (“quomodo”), qui rilevanti sotto il profilo giuscontabile, perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell’ente.
Poiché, per quanto riferito, la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale.
Al riguardo, la giurisprudenza contabile ritiene che l’ingresso di privato nel settore pubblicistico, sia subordinato alle seguenti condizioni:
1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.
La ricorrenza di tali condizioni dovrà necessariamente trovare campo di elezione nella motivazione del relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, la citata deliberazione della Sez. controllo Basilicata n.52/2017, in senso più ampio rispetto agli aspetti propriamente gestionali, ha correttamente avuto modo di affermare che: “…l’Ente dovrà considerare tutte le implicazioni dell’operazione prospettata sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali anche laddove si concretizzi nell’esercizio dell’autonomia negoziale (sul punto, cfr. deliberazione Sezione di controllo Veneto n. 903/2012). Va sottolineato, a tal riguardo, come l'utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l’adozione di moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli Enti Locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. L’inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, infatti, implica un’attenta valutazione da parte dell’ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione”.
Infine, la deliberazione n. 162/2018 della Sez. controllo Lombardia sottolinea che “la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità, .... soggetti aventi natura privata. Si consideri anche, sotto questo profilo, che l’art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Richiamando, poi, il precedente della Sezione (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 532/2017/PAR), la fondazione (anche di partecipazione) costituisce, sul piano strutturale, un’istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo.
La “sufficienza” patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, declinata nei termini di “adeguatezza” quale condizione per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 1, 7 comma 3, D.P.R. 361/2000, costituisce presupposto dell’esistenza stessa della fondazione, atteso che, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., il suo venir meno determina l’insorgere dell’alternativa tra la dichiarazione di estinzione e l’obbligatoria trasformazione della fondazione da parte dell’autorità governativa.
La possibilità per la fondazione di perseguire l’interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri...