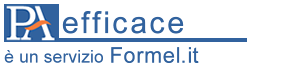APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI O ACCORDI TRA PP.AA.: CHI PROVVEDE?
APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI O ACCORDI TRA PP.AA.: CHI PROVVEDE?
Può accadere che una PA decida discrezionalmente o per necessità di stipulare una convenzione di quelle di cui all’art. 15 della L. 241/1990, un genere (genus) ben delineato dal Legislatore del 1990 e di cui quelle dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 rappresentano una mera specie.
08 Maggio 2025
Può accadere che una PA decida discrezionalmente o per necessità di stipulare una convenzione di quelle di cui all’art. 15 della L. 241/1990, un genere (genus) ben delineato dal Legislatore del 1990 e di cui quelle dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 rappresentano una mera specie.
Di che si tratta? Risponde egregiamente a questa domanda in recenti pronunce del Consiglio di Stato (cd. Diritto vivente) il cui contenuto vale più di 100 pagine di manuale di diritto amministrativo dedicate alla materia. Vedasi ad es. :
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 novembre 2023, n. 9842: (sintesi) le convenzioni tra enti locali ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una species dell’ampio genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 l. n. 241 del 1990. Premesso che in base all’art. 15, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990 le convenzioni fra enti pubblici devono essere stipulate mediante sottoscrizione digitale, sono nulli e quindi improduttivi di effetti gli accordi conclusi da enti locali, ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000, privi della forma digitale richiesta ad susbstantiam.
- Consiglio Stato sez.V sentenza 376-2024: (estratto) “Va infatti ricordato che le convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 altro non sono che una species del più ampio genus di accordi contemplati dall’art. 15 della l. n. 241 del 1990, come ancora di recente affermato dal Consiglio di Stato. Tale tipologia di rapporto emerge «con nitore tanto dal confronto testuale delle due disposizioni, quanto, più in generale, dal rapporto fra le coordinate logico-sistematiche, contenutistiche e teleologiche dei due testi legislativi che, rispettivamente, le contengono» (Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9842). A ciò consegue la necessità che la loro stipula soddisfi i requisiti di forma previsti da ridetta disposizione a carattere generale quale, a far data dal 30 giugno 2014, la sottoscrizione con firma digitale (art. 15, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dal d.l. n. 104 del 2013, successivamente modificato dal d.l. n. 145 del 2013). Essi inoltre sono sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ove non diversamente previsto. (…) Come pure già chiarito, infatti, allo stesso trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 15 della l. n. 241, introdotto per la prima volta dal d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012 (e poi modificato in seguito solo quanto alla decorrenza del vincolo di forma ivi delineato), che prescrive che gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni debbano essere sottoscritti con firma digitale, «pena la nullità degli stessi».Tale nullità “testuale” rende quelli non corredati dalla specifica tipologia di sottoscrizione inidonei a produrre un qualunque effetto giuridico. Ciò in quanto il comma 2 dell’art. 15 stabilisce che «per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3», che a loro volta rimandano, «ove non diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili». Il richiamo in parola, quindi, non può che essere riferito all’istituto civilistico della nullità, che, come noto, si connota, inter alia, per l’assoluta inidoneità dell’atto a produrre effetti giuridici: altrimenti detto, dal punto di vista degli effetti (ossia in un’ottica pragmatica attenta al dato funzionale della capacità concreta dell’atto di modificare la realtà giuridica), l’atto essenzialmente non esiste(sul punto, v. ancora Cons. Stato, n. 9842/2023, cit. supra).”
Sul sito dell’Anac è rinvenibile (v. https://www.anticorruzione.it/-/accordo-fra-p.a.-non-si-pu%C3%B2-usare-per-aggirare-la-concorrenza-e-il-codice-appalti ) la delibera 179 del 3.5.2023 che invita gli EE.LL. a non fare i furbi aggirando il Codice Appalti e quindi di fatto “la libera concorrenza e sottrarre l’affidamento alle regole del Codice appalti.” Attraverso detto istituto delle convenzioni tra PP.AA. ed esattamente l’ANAC rileva:
Il caso specifico
Il procedimento dell’Autorità ha preso il via da un esposto dell’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica) che ha segnalato varie criticità. L’Autorità ha avviato il procedimento contestando all’amministrazione il ricorso elusivo all’istituto dell’accordo convenzionale per l’affidamento dei servizi tecnici. L’accordo di collaborazione stipulato tra enti pubblici, infatti, è previsto dall’articolo 15 della legge n.241/1990 in caso di svolgimento di attività di interesse comune. Tuttavia, data la natura pubblicistica degli enti di riferimento, sono sorte perplessità in merito all’effettivo esercizio in comune delle attività e in merito alla previsione di un compenso. In particolare, ha evidenziato l’Autorità, la “scansione dei ponti”, ossia il rilievo operato con laser scanner o termo scanner o strumenti simili, e l’esecuzione di prelievi e prove di laboratorio sui materiali da costruzionesono a tutti gli effetti servizi di ingegneria e architettura e in quanto tali non possono essere affidati con procedure diverse da quelle previste dal Codice appalti.
La posizione di Anac
Secondo Anac, nel caso in esame, non ci sono i requisiti per la stipula di un accordo tra Pubbliche amministrazioni, che deve avvenire “nel rispetto delle finalità perseguite dalle direttive europee in tema di contratti pubblici e concessioni, vale a dire la libera circolazione dei servizi e la libera concorrenza pertanto, detti accordi devono avere ad oggetto attività non deducibili in contratti d’appalto”.
Anche recentemente, viene ricordato nella delibera, si è espresso il giudice amministrativo chiarendo che l’obbligo della gara possa escludersi solo in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune.
L’Autorità, pur condividendo una politica delle amministrazioni volta a valorizzare l’apporto collaborativo delle Università, in qualità di enti di ricerca e di conoscitori delle realtà in cui si localizzano in virtù del principio di prossimità territoriale, non può non stigmatizzare il ricorso elusivo agli accordi tra Pubbliche amministrazioni per l’affidamento di appalti di servizi che dovrebbero essere oggetto di procedure ad evidenza pubblica.
§
Ora leggendo detta delibera Anac si rinviene la seguente Gr. Amm.va citata in sintesi nella news di cui sopra:
- “ In materia di collaborazioni (((di PP.AA.))) con le Università il Supremo Consesso amministrativo ha osservato che “L’attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può pertanto trattare di un’attività ucrativa fine a sé stessa perché l’Università è e rimane un ente senza fine di lucro” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, sentenza n. 10).”
- “Anche recentemente si è espresso il giudice amministrativo chiarendo che l’obbligo della gara possa escludersi solo in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune (Tar Campania, Napoli, sezione I, sentenza n. 548/2019).”
E citata detta Gr. Amm.va così conclude l’ANAC correttamente in detto atto del 2023:“Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene doveroso chiarire che l’Autorità, pur condividendo una politica delle amministrazioni volta a valorizzare l’apporto collaborativo delle Università, in qualità di enti di ricerca e di conoscitori delle realtà in cui si localizzano in virtù del principio di prossimità territoriale, non può non stigmatizzare il ricorso elusivo agli accordi tra p.a. per l’affidamento alle medesime di appalti di servizi che dovrebbero essere oggetto di procedure ad evidenza pubblica. Anche recentemente è stato osservato che “la possibilità da parte della pubblica amministrazione di selezionare lo strumento degli accordi tra p.a. come modalità per il perseguimento dell’interesse pubblico sia circoscritta sia dalla tutela della concorrenza che dalla stessa ratio sottesa all’istituto. Se si ammettesse, perciò, l’ipotesi di un accordo tra pubbliche amministrazioni che avesse ad oggetto un determinato servizio, concretamente erogabile da un qualsiasi operatore economico, verrebbe meno non solo la finalità di semplificazione, ma si potrebbe produrre una grave distorsione del mercato, il che non è ammissibile in un’ottica europea in cui gli operatori economici nazionali possono partecipare alle procedure aperte di quei Paesi che scelgono di procedere con gara” (Delibera n. 496 del 10 giugno 2020).”
Certamente le PP.AA. non corrono il rischio di incorrere in tale elusioni (chi scrive ne vede molte in giro sui siti web di PP.AA. in Amm. Trasp. esattamente) allorché in qualità di Stazioni Appaltanti (SA) non qualificate (SAnQ) devono per forza affidare ad altra PA quale Stazione Appaltante Qualificata l’esecuzione della gara previa stipula di un accordo, perché è lo stesso D.Lgs. 36/2023 che lo impone all’art. 62 comma 9 ove dispone testualmente:
9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante *apposita convenzione*(((* parte nuova ex D.Lgs. 209/2023: prima c’era scritto“altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.”). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”
Detti accordi o convenzioni non sono onerosi per la PA Sa Committente detta ‘delegante’ cd. Ma la SAnQ deve corrispondere alla SAQ quota parte degli incentivi dedicati alla produttività specifica del personale del cd. Gruppo di Lavoro della...