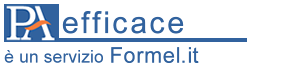SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO: QUALI I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI NOMINABILITÀ DI UN SOGGETTO A CARICA DI ORGANO AMMINISTRATIVO DI DETTE SOCIETÀ?
SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO: QUALI I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI NOMINABILITÀ DI UN SOGGETTO A CARICA DI ORGANO AMMINISTRATIVO DI DETTE SOCIETÀ?
23 Ottobre 2025
00 – IN GENERALE SULLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO.
Le società a controllo pubblico, secondo i dettami del D.Lgs. 175/2016, rappresentano per Dirigenti e Funzionari di Enti Locali 'partecipanti' ad esse e quindi vigilanti sulle medesime, un autentico terreno gestionale minato per quanto concerne i seguenti aspetti, nonostante abbiano natura giuridica di enti privati e non PA (ovvero soggetti pubblici):
a) la nomina e la gestione dei relativi Amministratori, che non sono propriamente loro 'dipendenti' (cioè lavoratori subordinati reclutati dalle stesse);
b) il reclutamento e la gestione dei relativi 'dipendenti' (cioè lavoratori subordinati reclutati dalle stesse), Dirigenti inclusi;
c) regime della TRASPARENZA dei relativi atti/provvedimenti e delle relative attività.
Soffermandoci brevemente quanto doverosamente in apertura sulla loro natura giuridica devesi dire che trattasi di questione/tema relativamente complesso, caratterizzato da un dualismo che vede la prevalente natura privatistica di dette società coesistere con l'applicazione ad esse (relativamente ad alcune attività/loro aspetti gestionali) di una disciplina speciale di diritto pubblico dovuta (sua ratio!) alla partecipazione e al controllo esercitato dall'amministrazione pubblica.
Questa impostazione trova ormai fondamento a livello normativonelTesto Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ma è anche ribadita dalla giurisprudenza, in particolare quella della Corte di Cassazione e della Corte dei conti e dal Consiglio di Stato.
Indicazioni Normative (TUSP): D.Lgs. 175/2016.
Il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) definisce il quadro normativo di riferimento per le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo.
- Natura Privatistica cd. residuale:l'art. 1, comma 3, del TUSP stabilisce che, per tutto quanto non espressamente derogato dal Testo Unico, alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme sulle società contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali, confermando in linea di principio la natura di soggetto di diritto privato della società.
- Diritto Speciale: Il TUSP introduce un diritto speciale (derogatorio e prevalente) per le società a partecipazione pubblica, in particolare per quelle a controllo pubblico (e ancor più per quelle in house), che le assoggetta a vincoli e obblighi tipici del diritto pubblico in materie "sensibili", quali:
- Finalità e Oggetto Sociale: Limitazioni sulle attività che possono essere svolte (Art. 4).
- Organizzazione e Personale: Norme specifiche sul reclutamento e sui compensi degli amministratori e dei dipendenti (Artt. 11 e 19).
- Controlli: Obblighi di trasparenza, governance e controllo da parte dell'amministrazione (Titolo III).
- Procedure Concorsuali: L'Art. 14 prevede la loro assoggettabilità alle procedure sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) e sul concordato preventivo, ulteriore elemento di matrice privatistica.
- Definizione di Controllo: Ai fini del TUSP, il "controllo" è definito, in generale, come la situazione descritta dall'Art. 2359 del Codice Civile (controllo di diritto, di fatto o contrattuale), ma con una lettura estensiva che include anche altre forme di influenza determinate da norme statutarie o patti parasociali, specialmente sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche (Art. 2, comma 1, lett. b e m).
Previsioni Giurisprudenziali
La giurisprudenza ha storicamente affrontato il problema della "doppia natura" di queste società, distinguendo tra l'ente societario e l'ente pubblico socio.
- Corte di Cassazione (Sezioni Unite):
- Natura Privatistica dell'Ente: La Suprema Corte ha costantemente ribadito che la società di capitali non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possieda in tutto o in parte le azioni (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4991/1995; n. 17287/2006). L'azione dell'ente pubblico come socio deve, in linea di principio, esercitarsi con gli strumenti del diritto societario, anche se finalizzata all'interesse pubblico.
- Ripartizione di Giurisdizione: Le controversie attinenti all'atto di revoca degli amministratori (espressione di un potere che deriva dalla qualità di socio) sono state spesso ricondotte alla giurisdizione ordinaria, salvo i casi in cui la decisione del socio pubblico si configura come esercizio di un potere pubblicistico.
- Corte dei Conti:
- Responsabilità Erariale: Nonostante la natura privatistica della società, la giurisprudenza contabile ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale cagionato dagli amministratori e dipendenti di società a controllo pubblico (soprattutto in house), quando il danno colpisce indirettamente il patrimonio pubblico dell'ente partecipante (danno alla partecipazione) o il danno si configura come conseguenza della mala gestio dell'interesse pubblico sotteso (cfr. Art. 12 TUSP).
- Consiglio di Stato:
- Equiparazione all'Ente Pubblico: Il giudice amministrativo può equiparare una società a un ente pubblico solo in presenza di una norma esplicita o quando essa svolge un'attività che è espressione di un potere pubblico, ai fini dell'applicazione di specifiche discipline (es. accesso agli atti[v. CdS Sez. VI sent. N. 2660/2015], trasparenza[v. CdS Sez. VII sent. 860/2023] , Codice dei Contratti Pubblici [v. CdS Sez V sent. N. 8542/2023: se ODP[1] = Organismo di Diritto Pubblico deve applicare il Codice degli appalti che seguono le PP.AA.). In generale, per le società in house (società a controllo pubblico totale che agiscono come longa manus dell'ente controllante), è più frequente l'applicazione di norme di diritto pubblico.
In sintesi, per chiudere questo quadro generale d'apertura, le società a controllo pubblico sono società di diritto privato che operano in un contesto normativo ibrido, dove il diritto societario si applica in via residuale, ma è affiancato e spesso derogato da un diritto speciale pubblicistico (il TUSP) che mira a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche e il perseguimento degli interessi collettivi.
Dunque le 'incursioni' del diritto pubblico espresso (dal Legislatore) o ritenuto applicabile dalle varie giurisdizioni sono innumerevoli ed insidiosi per i neo-addetti ai lavori, anche oltre i tre aspetti sopra evidenziati alle lettere a), b) e c), che più però interessano per il momento lo scrivente.
Quanto all'esatto perimetro nozionistico della società a controllo pubblico e relativi confini con quelle meramente 'partecipate' dovrebbe dirsi in prima battuta che potrebbe essere esaustivo leggere l'Orientamento della Struttura di controllo del MEF datato Roma, 15 febbraio 2018 - Orientamento(ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) - Oggetto: la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito “TUSP”). (v. link https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/orientamento_struttura_di_monitoraggio_mef-dt_15_febbraio_2018.pdf atteso che quello del MEF relativo a tale orientamento è disattivato).
Ma recentemente con la Sentenza del 23.09.2021 il Tar Lazio ha pronunciato sul ricorso interposto da ASSTRA e da altre imprese associate, difese dallo studio Massimo Malena & Associati, per l'annullamento dell'Orientamento adottato nel febbraio 2018 dal MEF ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.Lgs. 175/2016 (c.d. TUSP). Con il predetto Orientamento, il Ministero ha ritenuto di considerare società a controllo pubblico – e non meramente partecipate – quelle società in cui la partecipazione nell'impresa da parte di più PA risulta maggioritaria “anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”.
Il Tribunale, pur definendo in rito il giudizio con una pronuncia di carenza di interesse, ha rilevato la “la natura non provvedimentale dell'atto impugnato e della sua inidoneità a produrre effetti pregiudizievoli diretti ed attuali nella sfera giuridica soggettiva delle ricorrenti”. In buona sostanza, il TAR laziale ha ritenuto di considerare l'Orientamento alla stregua di una “circolare interpretativa”, quindi priva di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo. Conseguentemente non sorge l'interesse ad un'impugnazione autonoma dello stesso. Il Collegio conclude affermando che le ricorrenti (o il soggetto inciso da un eventuale provvedimento sanzionatorio del Ministero) “potranno impugnare gli eventuali provvedimenti applicativi [n.d.r. dell'Orientamento] domandando, contestualmente, l'annullamento ovvero la disapplicazione dell'atto oggetto dell'odierna impugnazione”.
Tuttavia, venendo all'oggi (2025), la Corte dei Conti Marche Sez. Controllo in delibera 63/2025/VSG sulla questione, esaminando le razionalizzazioni ex art. 20 TUSP intraprese dal Comune di Ancona ricorda e afferma i seguenti ulteriori sviluppi giurisprudenziali anche del giudice amministrativo:
“(…) va rilevato come, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, risulta “sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile” (indirizzo recentemente ribadito da Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 87/2024/REF).
In base a tale interpretazione, affinché la società possa qualificarsi come “a controllo pubblico” non occorre – come invece sostenuto da altro indirizzo, seguito in particolare da parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. TAR Emilia – Romagna, sent. n. 78 del 14 febbraio 2023) – la formalizzazione di meccanismi di coordinamento tra i vari soci pubblici (ad es. a mezzo di patti parasociali, clausole statutarie o norme di legge) per l'adozione delle principali decisioni strategiche, essendo sufficiente che la sommatoria delle partecipazioni pubbliche porti a ravvisare in capo alla pubblica amministrazione, unitariamente intesa, la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
Tale impostazione è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 3880 del 2023, nella quale – nel delineare i requisiti caratterizzanti la fattispecie del “controllo pubblico” con riguardo al caso di partecipazioni possedute nella medesima società da una pluralità di enti pubblici – si è affermato come “sia nel TUSP del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del comma 1, basterebbe allora che il soggetto “Pubblica amministrazione” unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”.
Anche il Consiglio di Stato è dunque pervenuto ad un'interpretazione collimante con quella offerta dalle Sezioni riunite in sede di controllo, nonché dalla Struttura competente del MEF (art. 15 TUSP) nel proprio atto di indirizzo del 18 15.2.2018. ”.
Quindi sui suddetti confini definitori della società a controllo pubblico possiamo dire che è scesa la parola fine al dibattito insorto post 2018.
Qui, nel presente scritto ci soffermeremo, invece, in particolare, sulle incursioni attinenti la nomina e la gestione degli Amministratori di dette società in controllo pubblico, quindi l'aspetto della lettera a) indicata in apertura, riservando ad altri separati futuri scritti approfondimenti sui settori di cui alle lettere b) e c).
01 – NOMINA E GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO
“Amministratori” cioè?
E' presto detto con lo stesso TUSP? Neppure per sogno: nel relativo art. 2 dedicato alle “Definizioni” di essi non v'è definizione. Si sa solo, ex art. 11 TUSP, che:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di societàa controllo pubblicodevono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto
- dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, (((ma vedi sotto il rinvio generaleal D.Lgs. 39/2013 operato dal comma 14: curioso quindi questo periodo del comma 1 !!!)))
- e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è (((=deve essere))) costituito, di norma, da un amministratore unico.(((ERGO: ORGANO MONOCRATICO = UNA SOLA PERSONA: regola!)))
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società
- sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri ((((eccezione))),
- ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura(((cd. di controllo del MEF))) di cui all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratoridelle società a controllo pubblico, le amministrazioni (((controllanti-nominanti))) assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. (((= LEGGE 12 luglio 2011 n. 120 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 174). - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati, il cui art. 3 co. 1 recita “1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.”)))
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza], previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta (3) .
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere (((al contempo)))dipendenti delle amministrazioni pubblichecontrollanti o vigilanti (((v. infra comma 12 cosa ne consegue ove ricorra tale ipotesi: “aspettativa non retribuita” quali dipendenti! Ergo non è astrattamente impossibile, ma scatta ex lege l'aspettativa non retribuita per i 'dipendenti'))). Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
12. (((v. sopra comma 8 ))) Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (4) .
16. Nelle società a (((mera))) partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Quanto alla nozione di “Amministratori”, assente nel testo del d.Lgs. 175/2016, devesi dire come al seguente link https://www.anticorruzione.it/en/-/guida-all-applicazione-della-legge-nei-casi-di-incompatibilit%C3%A0-e-inconferibilit%C3%A0 è rinvenibile il seguente documento dell'ANAC “Guida all'applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilitàDate:09 gennaio 2023”come l'ANAC ivi spiega in tale guida v'è (tra 3 documenti) il Documento n. 2 recante undici 'pillole' esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità ei relativi riferimenti normativi. Tra le 'pillole' ANAC che qui interessano si richiama l'attenzione degli addetti ai lavori alle pillole nn. 1 e 2 che si riportano in appresso in quanto delimitanti la figura/ruolo dell'Amministratore all'interno di dette società controllate:
Pillola n. 1
Al fine di valutare la riconducibilità di un incarico tra quelli di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico,è da ritenersi meritevole di particolare attenzione il potere di firma sociale, considerando che tale competenza gestionale implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente.
Riferimenti:
Art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013: “per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
Delibera n. 677 del 6 ottobre 2021: “Per ciò che attiene, in particolare, a quest'ultima competenza della firma sociale libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che essa implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto della società. In altro caso, infatti, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021) […] Al riguardo, si deve rilevare che nel caso in esame, a fronte della lata formulazione dello statuto – secondo cui il CdA ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – vi è in aggiunta il potere di firma libera del Presidente, ritenuto di per sé elemento significativo ai fini dell'inconferibilità dal precedente dell'Autorità sopra citato”.
Delibera n. 691 del 13 ottobre 2021: “Per ciò che attiene, in particolare, alla competenza della firma sociale cd. libera, si ritiene che la stessa sia meritevole di particolare attenzione considerando che implica il potere di obbligarsi validamente in nome e per conto dell'ente. In un altro caso, l'Autorità ha già ritenuto rilevante, ai fini dell'integrazione dell'inconferibilità, tale tipo di competenza gestionale (cfr. delibera n. 491 del 2021) […]”.
Delibera n. 491 del 16 giugno 2021: “Per quanto concerne il secondo aspetto, ovvero il potere di firma attribuito al presidente è emerso – a seguito di interlocuzione con l'ente interessato - che, analogamente a quanto suesposto, esso sia stato trasferito al consigliere delegato. In particolare, nell'atto di accettazione dell'incarico sottoscritto omissis, si legge che la omissis “dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica a lei conferita subordinando l'attestazione di insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al ruolo di Presidente al verificarsi, nel primo e imminente consiglio di amministrazione, dell'assegnazione di ogni qualsivoglia delega gestionale diretta al vice presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, come consentito dall'art. omissis dello statuto omissis, in modo tale da non avere alcun ruolo operativo o alcuna attività tipica di gestione”.
Dal verbale assembleare del omissis, emerge, infatti, che...