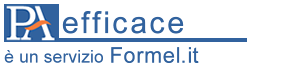Integrazione delle rette presso le strutture residenziali: riflessioni interpretative in termini di fisica applicata al diritto
obbligo del Comune di integrare le rette di degenza in strutture residenziali
Integrazione delle rette presso le strutture residenziali: riflessioni interpretative in termini di fisica applicata al diritto
a cura di Stefano Venturi
15 Ottobre 2025
Per comprendere bene la tematica è fondamentale avere ben chiara la distinzione tra ISEE (indicatore astratto) e reale capacità contributiva (disponibilità economica concreta)
In questi termini, si ritiene che il Comune, prima di farsi carico dell'integrazione della retta, abbia il diritto-dovere di accertare che l'utente non sia effettivamente in grado di farvi fronte con il proprio patrimonio e reddito.
Il presente scritto intende motivatamente e ragionevolmente esporre le ragioni giuridiche, logiche ed economiche (pur anche umane) per le quali, l'obbligo del Comune di integrare le rette di degenza in strutture residenziali, come sancito dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, non può essere automaticamente attivato sulla base del solo valore ISEE, ma deve essere preceduto da un accertamento della reale incapacità contributiva dell'utente. Si contesta l'interpretazione che equipara l'ISEE a un'automatica soglia di intervento pubblico, sostenendo che tale approccio è contrario ai principi del diritto e all'utilizzo accorto delle risorse pubbliche.
La tesi che il Comune debba semplicemente colmare la differenza tra la retta e l'ISEE si pone in netto contrasto con la natura dell'obbligazione e i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
- L'obbligazione principale grava sull'utente: Il pagamento della retta di ricovero è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il debitore di tale obbligazione è l'utente del servizio. Ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. L'intervento del Comune, come recita l'art. 6 della Legge 328/2000 ("assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione"), è chiaramente di “natura sussidiaria e non principale”. Esso si attiva solo nel caso in cui il debitore primario non sia in grado di adempiere.
- L'ISEE non è una limitazione di responsabilità patrimoniale: L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è, per sua natura, un “mero indicatore sintetico” della situazione economica del nucleo familiare, ideato per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e per la valutazione di una condizione di bisogno ai fini assistenziali (come confermato anche dalla sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Terza, n. 652/2013). Non può in alcun modo essere inteso come una forma di limitazione della responsabilità patrimoniale, che deroghi all'art. 2740 c.c. Una persona proprietaria di un vasto patrimonio immobiliare non può pretendere che la collettività si faccia carico della sua retta solo perché il calcolo ISEE, per le sue peculiarità, non riflette appieno il valore concreto e reale del patrimonio.
Per altro, confrontare un costo reale (la retta di degenza) con un indicatore astratto (l'ISEE) è un'operazione illogica e irrazionale, che conduce a risultati iniqui e insostenibili per la finanza pubblica.
L'ISEE, pur essendo stato aggiornato con il DPCM 159/2013 per includere nuove voci, rimane un indice che non riflette la concreta disponibilità economica dell'utente. Esso non considera la liquidità effettiva, il valore reale di mercato dei beni immobili o le potenzialità reddituali non immediatamente monetizzabili. L'ente locale non può limitarsi a un mero calcolo formale ma ha il dovere di accertare la concreta situazione economica del soggetto, includendo ogni fonte di reddito e patrimonio, come l'indennità di accompagnamento (di cui si dirà in seguito) e il patrimonio immobiliare.
I funzionari pubblici inoltre, nell'espletamento delle loro funzioni, sono vincolati al principio di diligenza. Agire sulla base del solo ISEE, senza accertare la reale capacità di spesa del cittadino e il suo patrimonio, configurerebbe un comportamento gravemente omissivo, potenzialmente passibile di addebito per responsabilità amministrativa per danno erariale. L'utilizzo accorto delle risorse pubbliche impone di intervenire solo ed esclusivamente quando il debitore principale non sia effettivamente in grado di farvi fronte.
Una Similitudine dal Mondo della Fisica
A volerla vedere pure in termini fisici, immaginiamo di dover calcolare la forza totale applicata a un oggetto. Un fisico sa che non ha senso sommare grandezze fisiche diverse, come ad esempio un vettore forza (che ha una direzione e un verso) e una grandezza scalare temperatura (che ha solo un valore). Sarebbe un'operazione priva di logica e di significato scientifico, un errore fondamentale che porterebbe a un risultato irrazionale.
Allo stesso modo, nel campo del diritto e dell'amministrazione, è altrettanto illogico e assurdo comparare l'ISEE, che rappresenta un indicatore astratto, con la retta di ricovero, che rappresenta un costo reale e concreto.
La capacità economica di un cittadino è una grandezza complessa, un "vettore" che include non solo i redditi (flussi di denaro), ma anche il patrimonio (beni immobili, investimenti) e la liquidità effettiva. È un valore che ha una sua direzione e una sua intensità, e che deve essere misurato nella sua interezza.
L'ISEE, invece, è un "indicatore scalare" che fornisce un valore sintetico, ma non tiene conto di tutte le variabili. Per sua natura, non misura in modo completo la forza economica di una persona, ignorando o sottovalutando elementi come la reale liquidità o il patrimonio immobiliare.
Confrontare l'ISEE (la temperatura) con la retta (la forza) è un evidente errore concettuale. Per calcolare se una persona può sostenere un costo (la retta), l'amministrazione non può basarsi su un semplice "indicatore", ma deve considerare la grandezza vettoriale completa della sua reale disponibilità economica. Agire diversamente porta non solo a risultati irrazionali, ma anche a decisioni ingiuste e a un uso irresponsabile delle risorse pubbliche.
A) L'Indennità di Accompagnamento e l'Ingiustificato Arricchimento
L'indennità di accompagnamento ha una finalità specifica, ossia quella di supportare economicamente l'invalido non autosufficiente nelle spese per l'assistenza continua. Essa è una prestazione economica a scopo assistenziale e non un reddito.
Quando il soggetto è ricoverato in una struttura residenziale, l'assistenza continua viene garantita dagli operatori della struttura stessa e il costo è già coperto dalla retta. L'indennità di accompagnamento, in questo contesto, perde la sua causa, ovvero la sua ragione d'essere. Escluderla dal calcolo della capacità contributiva dell'utente, come spesso accade nel calcolo dell'ISEE, porta a un ingiustificato arricchimento del soggetto (o dei suoi familiari). Un concetto che si scontra con il principio di equità e che risuona con gli insegnamenti di Dante sulla morale pubblica. Nel suo Convivio, Dante riflette sulla necessità di un ordine morale che garantisca l'uso corretto delle risorse e il rispetto dei doveri verso la comunità. A riprova di ciò e seguendo questa linea interpretativa, giustamente il T.A.R. Veneto nella sentenza 652/2013 ha sottolineato che, "se ai suoi bisogni provvedono gli operatori della struttura assistenziale, non si può logicamente escludere che, ai fini della compartecipazione al pagamento... possa tenersi conto anche dell’importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento".
Il Comune ha il dovere di considerare l'indennità di accompagnamento come parte integrante della disponibilità economica dell'utente, al fine di evitare che la collettività si faccia carico di una spesa che il cittadino potrebbe sostenere con fondi già erogati per lo stesso fine.
La tesi che sostiene l'obbligo del Comune di integrare la retta solo in seguito a un accertamento della reale situazione economica dell'utente è l'unica che si concilia con i principi del diritto civile, con la natura sussidiaria dell'obbligo pubblico e con i doveri di diligenza e di accortezza nella gestione della cosa pubblica.
L'interpretazione che si limita a un calcolo automatico tra retta e ISEE è illogica, irrazionale e foriera di ingiustizia per la comunità. I giudici sono chiamati a compiere un'analisi sostanziale, non meramente formale, per evitare di rendere la responsabilità patrimoniale un mero principio astratto inapplicabile di fronte a un indicatore economico che, per sua stessa natura, non è idoneo a valutare la concreta capacità di adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Oltre alle predette argomentazioni giuridiche è da aggiungere che, un uso irrazionale delle risorse, come nel caso di un'integrazione automatica della retta basata sul solo ISEE, in termini astratti, espone pure i funzionari e gli amministratori a potenziali censure di natura erariale nei limiti in cui, il danno erariale si verifica quando una condotta illecita di un agente pubblico (funzionario o amministratore) causa un pregiudizio economico-finanziario alla pubblica amministrazione senza un valido motivo.
Nel caso specifico, l'ente locale è chiamato a tutelare l'interesse della collettività e a usare le risorse in modo oculato. Un intervento che non sia di natura sussidiaria, ma che si traduca in un onere per la comunità anche quando l'utente ha la capacità economica di provvedere autonomamente, costituisce socraticamente un'azione lesiva per l'erario.
L'integrazione della retta a un utente che possiede un patrimonio mobiliare o immobiliare significativo o altre forme di reddito non conteggiate nell'ISEE (come l'indennità di accompagnamento), costituisce un vero e proprio sperpero. In questo scenario, il denaro pubblico viene utilizzato per un fine che non è di reale bisogno sociale, ma per un'esigenza che l'utente stesso potrebbe soddisfare.
L'agire del Comune, che si pone come soggetto principale e non sussidiario nell'adempimento di un'obbligazione che spetta al cittadino, viola il principio di sussidiarietà. Il contributo pubblico non è un diritto incondizionato, ma un intervento che si attiva solo in caso di accertata necessità e in assenza di altre fonti di reddito o patrimonio.
Se il Comune si fa carico del pagamento di una retta senza aver prima verificato la reale impossibilità dell'utente di provvedervi e senza aver posto in essere le azioni necessarie per recuperare le somme anticipate, i funzionari e gli amministratori possono essere chiamati a risponderne personalmente.
In sintesi, la decisione di integrare la retta basandosi solo sull'ISEE, ignorando la reale situazione patrimoniale e reddituale, non è solo illogica e ingiusta, ma configura un'azione amministrativa imprudente che può esporre l'ente e danno erariale.
- La Gerarchia delle Fonti: Dalla Costituzione al Regolamento Locale
Iniziamo il nostro percorso nel complesso panorama dei servizi sociali partendo da un principio fondamentale: la gerarchia delle fonti normative. La Costituzione, pietra angolare del nostro ordinamento, stabilisce una chiara ripartizione delle competenze legislative. Allo Stato spetta il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quelle garanzie irrinunciabili che devono essere assicurate a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, senza distinzione. Alle Regioni, invece, è assegnata la competenza residuale in materia di servizi sociali, il che significa che spetta a loro l'organizzazione e la gestione pratica di tali servizi, nel rispetto dei principi statali.
I servizi sociali costituiscono per altro una “materia” residuale di competenza regionale come sottolineato anche recentemente dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 296/2012 secondo cui la Carta costituzionale “ascrive alla Regione una competenza legislativa residuale in materia di servizi sociali”.
Questa suddivisione di poteri ha trovato un'importante attuazione nel DPCM 159/2013. Questo decreto, emanato in adempimento dell'articolo 117 della Costituzione, ha sancito che la determinazione e l'uso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sia per l'accesso che per la compartecipazione al costo dei servizi, rappresenta un livello essenziale di prestazione. È un punto cruciale, perché ciò significa che l'ISEE non è solo un semplice strumento, ma un parametro imprescindibile che tutti gli enti devono utilizzare.
La disciplina dei servizi sociali è quindi definita da una normativa sovraordinata rispetto a qualsiasi regolamento locale. Un comune non può, per nessun motivo, ignorare o modificare i principi stabiliti dalla legge statale. A riprova di ciò, l'articolo 4 delle preleggi al Codice Civile afferma in modo inequivocabile che i regolamenti non possono mai contenere disposizioni contrarie alla legge.
In questo contesto, il regolamento comunale è una fonte normativa secondaria, il cui ruolo è attuare e specificare quanto stabilito dalla legge. Se un comune dovesse disciplinare in modo difforme la verifica della situazione economica degli utenti, si esporrebbe a una palese illegittimità, facilmente contestabile in sede giudiziaria. Una giurisprudenza ormai consolidata, come quella del TAR Lombardia (ordinanza n. 1288 del 29 giugno 2016), ha ribadito con forza che, nella materia dei servizi sociali, la normativa statale prevale su quella locale[1].
Da ciò deriva un postulato fondamentale: un comune, per quanto animato dalle migliori intenzioni, è obbligato a utilizzare esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dalla disciplina statale, ovvero il DPCM 159/2013, per definire sia l'accesso ai servizi sia il livello di compartecipazione economica. Qualsiasi tentativo di introdurre elementi o strumenti di valutazione diversi, per esempio per calcolare la situazione economica dell'assistito, sarebbe del tutto fuori luogo e privo di validità giuridica. Questo principio è ormai un punto fermo del nostro ordinamento. Di conseguenza, un regolamento comunale che disciplini i servizi sociali deve necessariamente rimanere all'interno del solco tracciato dalla normativa statale e regionale, a pena di essere dichiarato illegittimo.
- La Disciplina Normativa: Il DPCM 159 del 2013 e l'Integrazione delle Rette
Per comprendere appieno la complessa questione dell'integrazione delle rette nelle strutture residenziali, dobbiamo rivolgerci a una delle principali fonti normative in materia: il DPCM 159 del 2013. Questo decreto non solo ha riorganizzato il sistema dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ma ha anche svolto un'azione di pulizia normativa, abrogando i precedenti D.Lgs. 109/1998 e D.P.C.M. 221/1999.
Questa abrogazione formale è un evento di grande rilievo. Per anni, infatti, l'articolo 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/1998 aveva rappresentato un punto di frizione, poiché la sua applicazione suonava stonata con il nuovo impianto di competenze disegnato dalla riforma costituzionale del 2001. A seguito di tale riforma, la materia dei servizi sociali rientrava nella competenza residuale delle Regioni, e una legge statale che imponeva obblighi agli enti locali appariva priva di forza. L'abrogazione del 2013 ha dunque spazzato via un'ombra di illegittimità, sebbene a parere dello scrivente, tale norma avesse già perso la sua efficacia molto tempo prima.
Dal "vuoto normativo" creatosi è emerso un nuovo atto statale che torna a incidere sull'autonomia degli enti locali: il DPCM 159 del 2013. L'articolo 6 di questo decreto si concentra in particolare sulle prestazioni sociosanitarie e, al comma 3, affronta la tematica dell'integrazione delle rette, definendo una base di calcolo per le prestazioni erogate in strutture residenziali a ciclo continuativo.
Purtroppo, la normativa non sembra aver colto la vera essenza del problema. La questione non è semplicemente calcolare un ISEE per concedere un contributo. Si tratta di stabilire chi, in assenza di disponibilità economiche concrete, sia tenuto a farsi carico dell'integrazione della retta. In altre parole, a un ente locale non interessa tanto il valore astratto dell'ISEE, ma la reale e tangibile capacità economica dell'utente. Se una persona ha un'entrata mensile di 500 euro ma possiede cinque immobili, non è logico che la collettività debba intervenire sulla base di un indicatore che non riflette la sua vera ricchezza.
L'ISEE, infatti, è un semplice indicatore, un "termometro" della situazione economica, mentre l'integrazione della retta rappresenta un costo effettivo che, per sua natura, grava sull'utente del servizio. L'ultimo comma dell'articolo 6 della Legge 328/2000 è molto chiaro: il Comune interviene solo per l'“eventuale integrazione economica” quando il ricovero è necessario. Questo "eventuale" non è un termine casuale. Implica che l'obbligo del Comune scatta solo quando l'utente non è in grado di far fronte al costo della retta con le proprie risorse, che includono non solo le entrate ma anche il patrimonio.
Questa interpretazione si basa su solidi principi giuridici:
- Omogeneità delle grandezze: Il pagamento della retta è un'obbligazione pecuniaria (art. 1192 c.c.). L'ISEE, invece, è un indicatore. Non si possono confrontare due grandezze non omogenee. L'ente deve versare il corrispettivo solo se il debitore principale (l'utente) non può farlo.
- Responsabilità patrimoniale: Secondo il principio cardine dell'articolo 2740 c.c., il debitore risponde dei suoi obblighi con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Solo se il suo patrimonio non è sufficiente, il Comune deve intervenire in via sussidiaria.
- Diligenza del funzionario: Un funzionario che si limitasse a pagare l'integrazione sulla base del solo ISEE, senza accertare la reale situazione economica, potrebbe essere accusato di danno erariale per non aver agito con la dovuta diligenza e aver utilizzato le risorse pubbliche in modo non oculato.
In sostanza, un cittadino con un reddito insufficiente ma con un vasto patrimonio immobiliare dovrebbe provvedere all'alienazione o allo sfruttamento economico dei suoi beni per far fronte ai costi. Sarebbe contrario al buon senso civico e a ogni regola di equità che una persona con un patrimonio considerevole, sul quale l'ISEE incide solo in minima parte, debba essere assistita economicamente dalla collettività. Il TAR Veneto, con la sentenza n. 652/2013, ha confermato questa linea, sottolineando che l'ISEE non è una forma di limitazione della responsabilità patrimoniale.
- La Natura del Rapporto: Non un semplice Contratto, ma un rapporto pubblicistico, tra necessità e libertà Personale
Il rapporto tra una struttura residenziale e il suo ospite è, per sua natura, un legame del tutto particolare, ben lontano da un comune rapporto contrattuale. Sebbene si parli di "rapporto di ospitalità", è raro che l'ospite abbia scelto di risiedere in tale struttura con piena consapevolezza e volontarietà. Spesso, questa decisione è il risultato di una necessità ineludibile, imposta da condizioni di salute precarie e dalla mancanza di un'alternativa valida.
Questa situazione evoca le parole di Edgar Allan Poe che introducono il suo racconto Ligeia: "L'uomo non cede agli angeli, né interamente alla morte, se non per la debolezza della sua minuscola volontà". In questo contesto, l'ingresso in una struttura non è una scelta volontaria, ma il segno di una necessità che va oltre la volontà del singolo. L'utente non ha concordato il costo del soggiorno né i dettagli del servizio, che sono stabiliti unilateralmente dalla struttura attraverso tariffe predefinite.
Per tali ragioni, è riduttivo definire questo rapporto come un semplice contratto, e persino come un "contratto imposto". Il rapporto tra la struttura residenziale e l'utente ha una natura profondamente pubblicistica. Nonostante la firma di moduli e formulari al momento dell'ingresso, questi atti non definiscono un accordo tra privati, ma formalizzano un legame che affonda le sue radici nei principi costituzionali.
Il nostro ordinamento, fondato sul principio di solidarietà sociale, riconosce alle persone anziane non autosufficienti il diritto, di natura normativa e non contrattuale, di essere accolte e assistite in una struttura idonea, indipendentemente dai loro mezzi di sussistenza.
Questo diritto "paralizza" lo strumento contrattuale tradizionale. L'accordo tra le parti viene infatti etero-integrato, cioè completato, da una complessa e dettagliata disciplina di diritto pubblico. Questa disciplina fissa gli standard qualitativi minimi del servizio, stabilisce i requisiti per l'accreditamento delle strutture e definisce i costi. In sintesi, il rapporto non è una libera negoziazione, ma la concretizzazione di un diritto sociale garantito a tutti i cittadini.
L'esigenza di un ricovero in una struttura residenziale solleva una questione di profonda delicatezza, che tocca uno dei valori più sacri della nostra Costituzione: la “libertà personale”. L'articolo 13 della Carta Costituzionale stabilisce in modo inequivocabile che tale libertà è inviolabile e può essere ristretta solo in casi e modi previsti dalla legge e con un atto motivato dell'autorità giudiziaria.
Ci si interroga, pertanto, se l'inserimento in una struttura, che di fatto comporta una restrizione della libertà dell'anziano, debba richiedere l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria. La questione diventa particolarmente spinosa quando l'utente non è in grado di esprimere il proprio consenso o, peggio ancora, esprime un esplicito diniego. Mentre in Paesi come la Spagna questa procedura è standard (art. 271 del Codice Civile spagnolo), in Italia la questione non sembra essere affrontata con la dovuta serietà. Si tende a considerare l'inserimento un atto di natura pubblicistica, ritenendo che la mera attestazione di non autosufficienza sia un presupposto sufficiente per il trasferimento, indipendentemente dalla volontà dell'interessato.
Questa impostazione, tuttavia, non tiene conto di un principio giuridico fondamentale: il fisiologico deterioramento delle capacità cognitive non equivale automaticamente a una totale perdita della capacità di agire o di intendere e di volere. Si può sostenere, piuttosto, che l'inserimento in struttura, con la conseguente compressione della volontà della persona, sia un'azione assistenziale necessaria e doverosa, che agisce esclusivamente a vantaggio di un soggetto che non sarebbe più in grado di provvedere adeguatamente a sé stesso. Questa necessità, e solo questa, può giustificare un'intrusione nella sfera giuridica del cittadino.
Spero che questa riflessione spinga a una valutazione più attenta e individualizzata di ogni singolo caso. Del resto, gli aspetti giuridici non sono irrilevanti. Basti pensare alla firma di un'istanza d'ingresso da parte di un familiare senza un valido potere di rappresentanza, che rende l'atto inefficace. Se l'inserimento è davvero "necessario", a cosa serve la firma di un parente? E se è un intervento "necessario" e "indilazionabile" come prescritto dalla norma, come si concilia la sua urgenza con l'esistenza di liste d'attesa? Ossia come può conciliarsi una lista d’attesa con un intervento che taluno ha ritenuto necessario e quindi indilazionabile?
- "L'eventuale" integrazione della retta: un significato chiaro
Cosa si cela dietro quel piccolo, ma cruciale, avverbio: "eventuale"? Per anni, le aule dei tribunali hanno cercato una risposta a questa domanda, mentre la soluzione si trova, in realtà, nella semplice logica e nella grammatica italiana. Mettiamo da parte preconcetti e interessi, e analizziamo la questione con gli strumenti del diritto e del buon senso.
L'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000 stabilisce che, per i soggetti che necessitano di un ricovero stabile, il Comune di residenza assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione della retta. La norma, successiva all'introduzione dell'ISEE, postula un concetto logico inequivocabile: si "integra"...